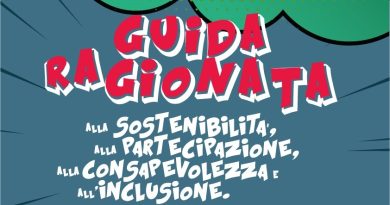La potenza comunicativa di Eleonora Duse
Nel centenario della morte della “Divina”, il prof. Pierfranco Bruni rilegge D’Annunzio – e la svolta del teatro del primo Novecento – attraverso la storia d’amore con la sua musa
Recentemente ho avuto il piacere di vivere una bella esperienza, partecipando alla serie di incontri, avviati tra le province di Bari e BAT, con l’obiettivo di ricordare Eleonora Duse nel centenario della morte. Relatore d’onore il Prof. Pierfranco Bruni, candidato dalla Regione Puglia al Nobel, che ha presentato il suo ultimo volume: “Con le sue labbra le suggella le labbra spiranti”, edito da Pellegrini.
Nel pregevole libro, Bruni ritorna a scrivere di D’Annunzio ripercorrendo la storia d’amore con la sua musa, l’attrice Eleonora Duse. Un rapporto che ha segnato la storia del teatro del primo Novecento e l’esordio del cinema muto.

Il significato del titolo
Il titolo del libro richiama un recitativo del dramma dannunziano “Francesca da Rimini”, in cui la Duse veste gli inquieti panni del V Canto dell’Inferno di Dante. Ed è proprio la Duse che – insieme a Sarah Bernhardt, Marta Abba, Mata Hari – costituisce il fulcro del lavoro di Bruni. Un’anabasi interiore, una drammatica discesa agli inferi che termina con il tentativo di risalire a guardare la danza delle nietzschiane stelle.
Il binomio arte-vita
Gli struggenti dialoghi tra Eleonora e Gabriele “sceneggiati” magistralmente dall’autore restituiscono una passione non solo “letteraria” (ossia della finzione), bensì anche “carnale”, della vita intesa come arte, pronta a declinarsi nelle nuances della sacralità del mistero. Lo stesso Bruni sottolinea: «Ho sempre amato Eleonora Duse. La teatralità la recita il tragico. Da quando ero ragazzo ho visto in lei la metafora del fascino del mistero del mito. La Divina, come la chiamò Gabriele, resta dentro di me».
Ritornando sui dualismi arte-vita e finzione-realtà, va rilevato che Bruni intreccia la sua vita con il viaggio di Eleonora e Gabriele. Da questo intreccio fa parte anche la spiegazione fornita dall’autore sulla genesi del libro: «Ho trovato in un cassetto della scrivania di mio padre, nella casa in Calabria, il testo che segue. Non so se sia mio o di un altro io o di mio padre. Non cambierebbe nulla. Anzi. L’ho rubato da un cassetto e ora lo pubblico così come l’ho trovato. Commetto il reato di appropriazione indebita. Non ho corretto nulla. I lettori possono fare tutte le considerazioni opportune e anche correggere con il blu o il rosso. Eleonora resterà sempre la Divina!».

Il volto e il corpo come “potente strumento di comunicazione”
Nata da attori girovaghi, Eleonora Duse impara a recitare sul “canovaccio”, che le dà temperamento e l’attitudine a trasformare in forza il dramma. Un fascino espletato in arte interpretativa, mutamento di aspetto e fisionomia. Del resto, come insegna la lectio dantesca l’Arte è “Trasfigurazione della Realtà”.
Nel 1878, ventottenne, si trasferisce a Napoli, dove subisce l’influenza e gli stimoli di due filoni coesistenti: la Commedia dell’Arte e la “Commedia Riformata” di Carlo Goldoni, in cui – semplificando – lo spazio dell’improvvisazione cede il passo alla stesura di un copione.
Fondendo le due “scuole di pensiero”, la Duse elabora un suo personale stile espressivo, affinando una mimica del volto e una presenza scenica del corpo che si traduce in potente strumento di comunicazione. In questo, è facilitata proprio dal canone della Commedia dell’Arte che, come si ricava anche dagli appunti grafici del Callot, non prevede che la donna indossi la maschera. La capacità di interagire con il pubblico, assiepato nelle piazze, è appannaggio esclusivo del volto, del gesto plateale e della postura.
Si può affermare senza tema di smentita che grazie alla Duse la tradizione teatrale non si è persa per strada, sopravvivendo al passaggio del tempo e all’avvento dell’era della tecnica. Basti pensare alla memorabile performance della “Divina” al suo esordio nel cinema muto.
Mino Miale